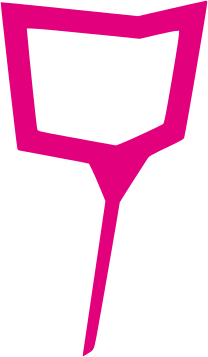Le ultime tendenze della gastronomia, fra rivisitazioni più o meno creative, piatti destrutturati e arditi esperimenti molecolari che hanno trasformato le cucine in avanguardistici laboratori, denotano una sempre più accentuata inclinazione al divorzio fra la nobile arte della cucina e le rispettabilissime esigenze primarie del nutrimento e dell’appagamento del palato. Sembra, questa, una costante di tutte le età di decadenza, in cui popoli, alla lettera, troppo sazi, arrivano a concepire il cibo come un orpello e, come tanti bambini viziati che cincischiano svogliatamente nel piatto, attendono l’intervento illusionistico che trasformi la prosaica incombenza di nutrirsi in inesausta fonte di meraviglia.
Talvolta, però, dietro la meraviglia si affacciano i tratti dell’incubo, come dimostra l’indimenticabile banchetto del volgare arricchito Trimalcyone, descritto con maestria espressionistica da Petronio Arbitro nel Satyricon e immerso da Fellini, nel film omonimo, in una cupa atmosfera attraversata da oscuri presagi di morte. Anche in cucina, in definitiva, il sonno della ragione finisce per produrre mostri.
Senza scomodare accostamenti a sfondo psicanalitico, si potrebbe dire che il cibo sia una faccenda troppo seria per lasciarla ai soli cuochi alla moda, tanto più che la saggezza popolare meridionale interviene opportunamente ad avvertirci che “quando si mangia, si combatte con la morte”.
Nelle economie di sussistenza, come per qualche decina di secoli è stata anche quella dei vari territori calabresi, l’esigenza di nutrirsi e il cibo sono infatti questioni della più vitale importanza. Le cucine dei nostri territori, di conseguenza, sono state indelebilmente segnate dallo spettro della penuria e dall’esigenza di trasformare in nutrimento quasi ogni componente dei tre “regni” in cui veniva tradizionalmente suddiviso il creato, compresi innumerevoli vegetali spontanei – dalla comune borragine fino agli inusitati germogli di vitalba utilizzati come ingrediente di squisite frittate – e animali di ogni genere. A questo proposito, ricordo tuttora con vivo sconcerto i racconti di alcuni vecchi compaesani che mi descrivevano l’uso alimentare, un tempo frequentissimo dalle nostre parti, di placide creature boschive come ghiri e tassi, fino ad allora da me viste soltanto nei cartoni della Disney. Fu così che mi resi conto dell’esistenza di una realtà gastronomica parallela e non codificabile nei ricettari, appannaggio quasi esclusivo di gruppimaschili quali cacciatori, pastori o carbonai, a stretto contatto con l’ambiente dei boschi e che per secoli si erano alimentati in maniera del tutto simile agli eroi delle fiabe o dei racconti di avventura. Il benessere ha quasi completamente spazzato via questo mondo – benché qualcuno tuttora si ostini a resistere – e i gruppi di giovani maschi in cerca di avventure ormai finiscono malinconicamente, anche dalle nostre parti, ai tavoli di qualche pizzeria o nei fast-food annessi ai centri commerciali.
Eppure, quella fame atavica che spingeva a identificare come commestibili specie animali e vegetali che oggi ci provocano un sussulto, era anche il segno di una contiguità tra uomo e natura ormai irrimediabilmente persa. Anche senza ricorrere a esempi estremi, è innegabile che la gamma del commestibile, e quindi la varietà dei sapori a disposizione della cucina, era molto più ampia prima che, a partire dagli anni del miracolo economico e complice l’appiattimento del gusto, diffuso dall’industria alimentare, intervenisse anche in campo gastronomico un’omologazione in tutto e per tutto simile a quella culturale denunciata da Pasolini nei suoi Scritti corsari. Ed è altrettanto innegabile che, senza i procedimenti igienici dell’industria, i sapori fossero sicuramente più ruvidi e intensi, vicini alla terra e forse troppo forti per i nostri palati anestetizzati. E qui occorre specificare che le varie cucine tradizionali della Calabria avevano un’impronta prevalentemente contadina e pastorale e che le classi più elevate si distaccavano da quelle popolari solo per una maggior disponibilità di risorse,ma poco o nulla per quel che riguardava le preferenze alimentari. Certo, dal punto di vista del vitto quotidiano, le differenze di classe si facevano sentire eccome, ma il gusto era comune e i piatti delle occasioni festive, quando anche i poveri potevano concedersi qualche eccesso lungamente sognato, erano sostanzialmente uguali. Di fatto, la cucina di ogni giorno era legata, per gran parte della popolazione, solo ai prodotti della terra, erbe, ortaggi, ecc. e quella dell’abbondanza di carni e insaccati era più che altro un’aspirazione che si concretizzava piuttosto raramente: nei giorni dell’uccisione del maiale, durante il Carnevale e in occasione delle festività solenni.
Molte preparazioni, nate sulla spinta della necessità, in seno alle classi inferiori, venivano adottate universalmente perché estremamente appaganti sul piano del gusto. È così che sono nati piatti di geniale semplicità e sapore inimitabile, dalla tradizionale pasta con mollica di pane e acciughe salate, ancora in uso in molte case per il cenone della vigilia, alle varie preparazioni a base di patate – cibo povero per eccellenza –magari fritte a fuoco lento insieme a peperoni e altri ortaggi, fino a formare una specie di sformato croccante con cui si farciva la pagnotta che a metà mattina ristorava la fatica degli zappatori. Per non parlare della straordinaria fantasia dispiegata nel conservare ogni tipo di cibo; dalle innumerevoli preparazioni cui dava luogo la lavorazione del maiale, agli ortaggi sott’olio o in salamoia (ormai quasi in disuso quest’ultima), alle tantissime conserve di pesce – tipiche di una regione ricchissima di coste ma, a lungo popolata soprattutto nell’interno – fra cui quella che, insieme alla ’nduja, è uno dei simboli della gastronomia calabrese nel mondo: quella straordinaria conserva di neonata di pesce azzurro e peperoncino – che affonda forse le sue radici nel garum dei Romani – diffusa esclusivamente sulle nostre coste e chiamata rosamarina sul Tirreno, sardella sullo Ionio. Purtroppo, complici la globalizzazione e la pesca indiscriminata e sciagurata attuata per decenni, ormai i preziosi pesciolini sono sempre meno disponibili e le nostre industrie conserviere si rivolgono massicciamente al cosiddetto pesce ghiaccio, un minuscolo ectoplasma bianchiccio proveniente,manco a dirlo, dalle acque della Cina, che però nulla possiede dell’aspra forza salmastra dell’originale.
Incidentalmente, va notato come, sull’onda del crescente successo internazionale, anche la ’nduja – che deriva il nome,ma non le caratteristiche, dall’andouille del Calvados, insaccato di interiora di maiale, affumicato e aromatizzato con pepe nero, portato forse dalle truppe di Gioacchino Murat – si sia notevolmente ingentilita perdendo a mano a mano, almeno nella produzione su larga scala, il sapore originario. Del resto, i vari insaccati di interiora, che dell’andouille condividono invece le caratteristiche, e che un tempo erano assai diffusi, per la necessità di lavorare tutte le parti del prezioso animale, sono ormai quasi introvabili.
Ma, è questa forse l’unica vera caratteristica comune della variegatissima gastronomia calabrese, le specificità locali sono tali e tante che le sorprese davvero non finiscono mai. La scorsa estate, ad esempio, a Belmonte Calabro, stupendo paesino affacciato sul Tirreno, in una sperduta contrada, falcidiata dall’emigrazione e abitata ormai soltanto da pochissimi vecchi, ho avuto modo di assaggiare ’u gammune – nome derivato dal francese jambon o forse dallo spagnolo jamón – un salume di sublime soavità che è, né più né meno, la versione calabrese del culatello, solo leggermente diverso nella forma,ma in nulla inferiore, né quanto a delicatezza né quanto a rotondità del gusto, ai migliori esemplari del celeberrimo cugino emiliano. Più tardi ho scoperto che lo stesso tipo di insaccato, che un tempo doveva probabilmente essere diffuso in gran parte del territorio calabrese, si produce ancora a Nardodipace e nel circondario.
Anche questi pochi esempi bastano a dimostrare, credo, che le nostre tradizioni alimentari recano inscritte in sé, come in una grande autobiografia collettiva, le asperità di un’orografia particolarmente tormentata, la durezza delle condizioni di vita di braccianti, contadini, pastori e marinai, le credenze religiose e gli usi festivi, le tracce lasciate dalla lunga catena di dominazioni straniere, gli incontri e gli scontri con i vicini delle altre sponde del Mediterraneo.
Spiace davvero che a fronte di una simile ricchezza, la nostra ristorazione, a parte poche felicissime eccezioni, dimostri mediamente un’incultura e una sciatteria disarmanti, rifugiandosi, il più delle volte, in proposte banalissime che non rispecchiano minimamente né la varietà, né la specificità dei nostri territori. Ogni piatto autenticamente tradizionale è prima di tutto un documento storico e umano che, a saperlo leggere, ci parla, oltre il tempo e lo spazio, degli uomini e delle donne che lo hanno creato, delle loro condizioni materiali ovviamente,ma anche, e forse soprattutto, del loro universo simbolico e delle loro speranze, perché davvero la cucina è una faccendamaledettamente seria e, come recita il proverbio ricordato all’inizio: “quando si mangia si combatte con la morte”.
Testo tratto da La cucina calabrese di Grazia Furferi (Rubbettino)
Massimo De Pascale