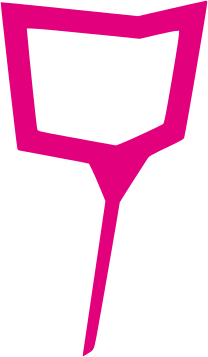Lampridio sosteneva che ai banchetti dell’eccentrico imperatore Eliogabalo non mancava una salsa di pesce inventata dai Sibariti nel 510 a.C., cioè lo stesso anno in cui la polis fu distrutta nella sanguinosa guerra con i Crotoniati. Secondo lo storico, che non dice da dove traesse la notizia, in quel drammatico anno, invece di occuparsi della guerra, i Sibariti, tenacemente attaccati alle delizie della vita, ordinavano ai cucinieri di sperimentare nuovi condimenti per i loro stomaci insaziabili!
Secondo le fonti letterarie il gáron, liquido dal sapore particolarmente aspro, era ottenuto dalla lavorazione di alcuni pesci e utilizzato come condimento in diverse pietanze. Plinio ci informa che nell’antica Roma il garum si otteneva facendo macerare nel sale intestini e scarti di alcune specie ittiche. I Greci iniziarono a produrlo dopo aver notato che le fumigazioni con la testa bruciata del pesce garos favorivano la fuoriuscita della placenta. Il gáron più gustoso si otteneva utilizzando lo sgombro, ma alcuni lo preparavano anche con un pesciolino poco pregiato che i Romani chiamavano acciuga e i Greci aphye. Isidoro scriveva che il garum era una salsa salata a base di pesce, elaborata anticamente con il pesce che i Greci chiamavano γάρον. Pur preparandosi con una infinita varietà di pesci, conservava tuttavia il nome originario.
Marziale scriveva che per fare il garum bisognava usare pesci grassi come salmoni, anguille, cheppie, sardine o aringhe e immischiarle con sale ed erbe aromatiche. Si preparava un vaso ben solido e impeciato, della capienza di tre o quattro moggi e vi si stendeva uno strato di aneto, coliandro, finocchio, appio, santoreggia, sclareia, ruta, menta, sisimbro, levistico, puleggio, serpillo, origano, betonica e argemonia. Si disponeva quindi un secondo strato di pesci interi (se grandi tagliati a pezzetti) e sopra si poneva un terzo strato di sale alto due dita. Con questi strati di erbe, pesci e sale, che si alternavano vicendevolmente, si riempiva il vaso fino alla sommità e si chiudeva con un coperchio. Dopo sette giorni, per venti giorni di seguito, due o tre volte al di, l’impasto veniva smosso fino al fondo con un palo di legno a forma di remo e col liquido che era colato si preparava la salsa o oenogarum. In ogni due sestari di liquido, si aggiungevano mezzo sestario di vino buono, quattro manate di erbe secche (aneto, coliandro, santoreggia e sclareia), una manciata di semi di fien greco e trenta o quaranta grani di aromi (pepe, cinnamono e garofano) finemente tritati. Il composto veniva quindi cotto in un tegame di ferro o bronzo fino a quando non si riduceva alla misura di un sestario. Prima che fosse cotto del tutto bisognava aggiungervi una mezza libbra di miele schiumato e, ancora bollente, doveva essere colato con un filtro fino alla limpidezza. Una volta raffreddato si conservava in un vaso ben impeciato pronto per condire le pietanze.
Un testo greco ci informa che il gáron (chiamato anche liculme) era preparato con interiora di pesci («massimamente atherine, o piccioli muli, o menule, o licostomi, o altri piccioli pesci») che, salate abbondantemente, venivano tenute lungamente al sole e continuamente rivoltate. «Invecchiato» dal caldo, l’impasto era posato in un cophino dal quale colava il gáron. Altri preparavano la salsa mescolando alici (o in alternativa licostomi, lacerti e sgombri) in un vaso in modo da farne un pane e vi aggiungevano due «sestari italiani» di sale per ogni mozzo di pesce. Lasciavano per una notte il miscuglio nel vaso, lo esponevano al sole e lo rimuovevano con verghe. Una volta fermentato, ad ogni «mozzo» di pesce aggiungevano due «sestari» di vino vecchio. L’anonimo greco ci informa, infine, che il gáron migliore, hermation o stillera, era preparato con interiora di tonno (thinno). Sulle frattaglie, mischiate con branchie e sangue del pregiato pesce, si spargeva abbondante sale e si lasciavano per due mesi in un recipiente.
Nel Geoponica si legge che il gáron veniva prodotto con intestini di piccoli pesci e soprattutto triglie, sardelle e acciughe. Raccolti e messi in vasche, venivano salati ed esposti al sole, quindi, una volta pronta la salamoia, si filtrava il prezioso liquido con un cesto. In certe zone per fare la salsa si utilizzavano sgombri, maccarelli e acciughe. Li mescolavano per bene, vi aggiungevano abbondante sale e li mettevano in quei contenitori che venivano usati per impastare ciambelle con farina d’orzo. Dopo averlo lasciato macerare per una notte, l’impasto si metteva in recipienti di terracotta e si esponeva al sole per due o tre mesi girandolo con un bastone ad intervalli regolari. Il gáron veniva infine versato in appositi recipienti (alcuni vi aggiungevano vino vecchio) che venivano sigillati col coperchio. Alcuni, per affrettare i tempi di preparazione del gáron, bollivano i pesci. Dopo aver testato la concentrazione del liquido (vi gettavano un uovo e, se affondava, voleva dire che mancava sale) mettevano i pesci in un recipiente di argilla, vi aggiungevano origano o mosto bollito e lo facevano cuocere senza però farlo bollire. Una volta raffreddatosi il liquido si versava in un colino per due tre volte finchè non si eliminavano le impurità. Il gáron migliore, chiamato aimátion, si otteneva con interiora, branchie e sangue di tonni che venivano cosparse di sale e messe in un vaso sigillato. Il liquido che si otteneva dopo due mesi veniva chiamato «salsa di sangue» (gáros aimátion).
Diversi scrittori romani, tra cui Varrone, Orazio, Apicio, Seneca, Marziale, Columella e Petronio, ci informano che il garum era utilizzato abbondantemente in cucina. Plinio annotava che era considerato una raffinatezza e le sue specie «infinite». Una qualità dal colore di vino melato vecchio era così fluida e buona che si poteva bere, mentre un’altra, fatta con pesci privi di squame, era riservata alle pratiche superstiziose della castità e alle sacre cerimonie giudaiche. Il garum veniva usato dai medici per placare il dolore nella bocca e nelle orecchie, per guarire ustioni, morsi di cani e coccodrilli, ulcere e infezioni. Secondo Columella il liquido aveva virtù terapeutiche anche in campo veterinario. Con esso si curavano le cavalle colpite da una terribile malattia (dimagrimento improvviso) che nell’arco di pochi giorni le conduceva alla morte. Alle mule malate di suppurazione si introduceva nella narice sinistra un sestario di ottimo garum mescolato con una libbra di olio e l’albume di tre o quattro uova.
Lungo le coste del Mediterraneo, soprattutto in Libia e Tunisia, esistevano diverse industrie per la preparazione del garum. In genere erano situate vicino al mare, avevano ampie vasche per l’essiccazione e la putrefazione, ambienti per lo stoccaggio e depositi per la conservazione. Ateneo, citando Strabone, ci informa che vicino alle isole di Eracle, presso Nuova Cartagine, si trovava la città chiamata Sgombroaria per gli sgombri che ivi erano pescati e con i quali si preparava il garón più pregiato. Plinio affermava che il garum migliore era preparato con gli sgombri allevati nei vivai di Cartagine Spartaria e che, con mille sesterzi, se ne ottenevano quasi due congi. Gli sgombri erano catturati specialmente in Mauritania e a Carteia, nella Betica, ma per la produzione della salsa erano rinomate anche Clazomene, Pompei, Lepcis, Antipoli e Turii. Manilio sostiene invece che il garum era fatto utilizzando grandi pesci e soprattutto i tonni. Pescati con le reti una parte veniva seccata e un’altra «conservata con i suoi succhi». Dalla loro lavorazione si otteneva un «liquido prezioso» costituito dalla parte migliore del sangue che, unito al sale, offriva «un gusto delicato alla bocca». Il resto dei pesci, una volta tagliati a pezzi, venivano mescolati e nella «scambievole corruzione» si otteneva un condimento adatto per i cibi comuni.
Le fonti letterarie, dunque, ci dicono che il gáron era una salsa di pesce che si produceva in molti centri del Mediterraeo e costituiva un’attività produttiva molto redditizia. C’era un gáron che si preparava con grandi pesci e un gáron con piccoli pesci, un gáron che richiedeva mesi di preparazione e un gáron solo alcuni giorni, un gáron che era molto costoso e un gáron a buon mercato, un gáron utilizzato nella cucina e un gáron nella medicina. Che i Sibariti avessero inventato il gáron è una tesi senza alcun fondamento e sostenuta peraltro da Lampridio, uno storico che, nonostante si dichiarasse paladino «d’esattezza storica», non aveva certo le carte in regola per essere preso sul serio.
Storici come Lampridio «accusavano» i Sibariti di avere inventato il gáron perché la salsa veniva considerata da molti schifosa e vomitevole! Ateneo conferma che il liquido, fatto di pesci salati e aceto, era un alimento particolarmente putrido e puzzolente. Per Plinio era pestilenziale e non poteva essere altrimenti, considerato che era il marcio di materie in decomposizione. Seneca ne condannava l’uso, definendolo preziosa distillazione di pesci corrotti, «salsa melma» che bruciava i ventricoli. Marziale sosteneva che odore e sapore erano nauseabondi e, per diffamare un certo Papilo, scriveva che questi, odorando un unguento profumato contenuto in un vasetto, diventava puzzolente come il garum. Apicio, autore del famoso ricettario, annotava che la salsa di pesce mandava un «cattivo odore» e indicava una serie di accorgimenti per «correggerla» (aggiungere soprattutto miele e gambi di lavanda).
Il ragionamento di Lampridio era quindi in un certo senso coerente: uomini normali non ritenevano prelibatezza un cibo dal sapore e dall’odore sgradevolissimi, persone sane di mente non ingerivano una salsa pericolosa per la loro stessa vita! I Sibariti evidentemente avevano raggiunto un tale livello di corruzione e degrado che anche quando mangiavano andavano contro natura. Non siamo in grado di stabilire se avevano ragione coloro che ritenevano il gáron un intingolo squisito o coloro che lo ritenevano uno schifo. Non siamo neanche in grado di stabilire se, come sostenevano alcuni, fosse un alimento particolarmente dannoso per la salute, mentre per altri un condimento altamente proteico. Ciò che a noi interessa sono le motivazioni ideologiche che stanno dietro la discussione sul gáron.
Il gusto indica l’ineguaglianza sociale sia con l’abuso che con la privazione del consumo di alcuni prodotti. Una pietanza è anche lo specchio della mentalità di un gruppo sociale. Il gáron sulla tavola dei nobili sibariti era probabilmente simbolo di potenza e ricchezza. La salsa piccante rivelava il bisogno di riaffermare il primato culturale e politico nella società. Essi si consideravano ceto superiore, con qualità che meritavano rispetto e deferenza dagli altri ceti. Gelosi dei loro privilegi, per riaffermare e rendere manifesta la loro supremazia, da sempre gli aristocratici hanno sentito il bisogno di distinguersi e rinnovarsi e lo hanno fatto attraverso mode estrose e bizzarre anche in campo alimentare.
Il gáron sulle tavole dei ricchi sibariti ricordava la distanza tra i nobili e le altre classi sociali. Questa distanza era legata ad una questione di gusto ma anche economica. La salsa di pesce era rara e particolarmente costosa. C’era un garum consumato a buon mercato ma era prodotto su scala industriale e con pesci di scarsa qualità. L’allex, sedimento non lavorato e filtrato del garum, costituiva lo scarto ed era usato soprattutto nella cucina povera. Isidoro precisava che il liquamen era diverso dal garum: era un «liquido» prodotto da piccoli pesci messi sotto sale, dal gusto simile a quello dell’acqua marina. Il vero garum, quello che richiedeva una complessa lavorazione ed era preparato con pesci pregiati, era accessibile solo ai ricchi e Plinio, non a caso, scriveva che, a parte i profumi, era il liquido più prezioso esistente al mondo. I ricchi Sibariti organizzavano sontuosi banchetti ma ciò che stupiva i loro ospiti erano soprattutto le salse preparate con aromi e alimenti provenienti soprattutto dall’Oriente. Seneca scriveva che il palato dei Romani si svegliava soltanto davanti a cibi che costavano cari e li faceva costare cari non un sapore straordinario o una qualche dolcezza del gusto, ma la rarità e la difficoltà di procurarli.
A molti la dieta sibaritica, e soprattutto salse di pesce come il gáron, appariva detestabile e contraria al buon senso comune, ma per gli aristocratici era la stessa autorità indiscussa della loro classe a sancire che il proprio gusto non era indegno e disprezzabile: da una stirpe nobile non poteva derivare alcuno scandalo. Le preferenze alimentari, pilastro dell’identità culturale, sono anche il prodotto dell’isolamento sociale. Il gáron stabiliva un elemento che segnava l’appartenenza alla casta, richiamava gli antichi privilegi del loro ceto, riaffermava la diversità nei confronti delle altre classi. Egemonia e superiorità nella società provenivano dalla ricchezza, ma erano manifestate simbolicamente anche attraverso mode culturali che agli altri ceti sociali apparivano inspiegabili e bizzarre.
L’ideologia alimentare dei nobili sibariti, basata su dismisura e stravaganza, veniva messa in discussione dai pitagorici che predicavano il limite e la semplicità. Pitagora, secondo Stobeo, era convinto che il cibo avesse una forte influenza negli aspetti della vita e sosteneva che un uomo non doveva unirsi ad una donna se era sazio o ubriaco, perché dall’unione non sarebbero nati «frutti armoniosi e belli, e nemmeno buoni in assoluto». Il filosofo condannava qualsiasi eccesso, ammonendo che nessuno doveva «passare la misura» sia nel bere che nel mangiare. Porfirio racconta che Pitagora metteva in guardia dall’eccesso del piacere più di ogni altra cosa, perché nessun’altra passione portava alla rovina e induceva a peccare come la «smoderatezza dal ventre». Incoraggiava i genitori ad abituare i figli ad alimentarsi correttamente e spiegare loro che ordine e misura erano nobili, mentre disordine e smoderatezza, turpi . Ricordava sempre ai concittadini che la terra offriva ogni ben di dio e li invitava a non contaminare il corpo «con pietanze empie!». Giambico ci informa che criticava duramente quei ricchi proprietari insaziabili che spingevano i cuochi ad inventare «preparazioni culinarie» ricche di «combinazioni di salse» che rendevano l’animo debole e stravagante.
Il gáron diventava dunque uno strumento politico per affermare l’una o l’altra ideologia. Un acceso dibattito sulla salsa di pesce si sviluppò anche nell’Impero Romano. Seneca, ad esempio, lo indicava come simbolo di coloro che si preoccupavano solo a godersi la vita. La depravazione e la dissolutezza dei Romani si manifestava anche e soprattutto nella gastronomia. Egli metteva in evidenza che non amavano gustare i sapori uno ad uno, ma volevano che tutti i gusti fossero mescolati in uno solo. Le vivande preparate dai cuochi venivano immerse nella stessa salsa al punto che il vomito non poteva presentare un miscuglio peggiore! Per i patrizi della città l’uso delle salse pregiate e stravaganti erano motivo di vanto, gloria e ostentazione, non si rendevano conto che in realtà esse erano solo causa di malattie inguaribili. Accecati dalla follia e dai piaceri della gola si facevano portare da ogni parte del mondo ogni sorta di cibo che i loro stomaci disfatti non erano neanche in grado digerire: vomitavano per mangiare e mangiavano per vomitare.
Se a Sibari il simbolo della crapula era Smindiride, a Roma era Apicio. Seneca denunciava che mentre i filosofi venivano costretti a lasciare la città perché sospettati di rovinare i giovani, uomini come Apicio, che aveva corrotto e «contaminato il secolo» con le sue lezioni di «scienza della gozzoviglia», venivano apprezzati e celebrati. Lo stesso Apicio, dopo avere gettato in ghiottonerie cento milioni di sesterzi e dopo essersi divorato il patrimonio in una baldoria dopo l’altra, schiacciato dai debiti, ad un certo punto fu costretto a verificare i suoi conti: calcolò che gli sarebbero rimasti dieci milioni di sesterzi e, come se gli toccasse vivere nella fame più nera se fosse vissuto con tale somma, si uccise col veleno. Per Apicio, uomo dall’animo depravato e dissoluto, l’ultima bevanda fu la più salutare: era in vita che mangiava e beveva veleni, quando traeva non solo diletto ma vanto da banchetti smisurati, quando ostentava i suoi vizi, quando attirava l’attenzione della città sulla sua brama di lusso, quando allettava la gioventù ad imitarlo. Seneca scriveva che i bisogni del corpo erano quelli di allontanare il freddo e calmare la fame con l’alimentazione: le pene che gli uomini si davano per ogni ulteriore brama erano dovute ai vizi, non alle necessità. E ricordava ai suoi concittadini i valori degli antenati i quali mangiavano cibi sani che si procuravano con le loro mani, vivevano in case i cui soffitti non sfavillavano d’oro e pregavano nei templii che non luccicavano di gemme. Consapevole che ormai era difficile riportare la ragione, per punire quei Romani che come Apicio stavano portando la città alla rovina invocava la nemesi: «Gli dèi e le dee mandino in rovina questi individui, la cui brama di lusso non bastano a fermare i confini del grande impero» .
Prof. Giovanni Sole
Docente di Storia delle Tradizioni Popolari, Università della Calabria.